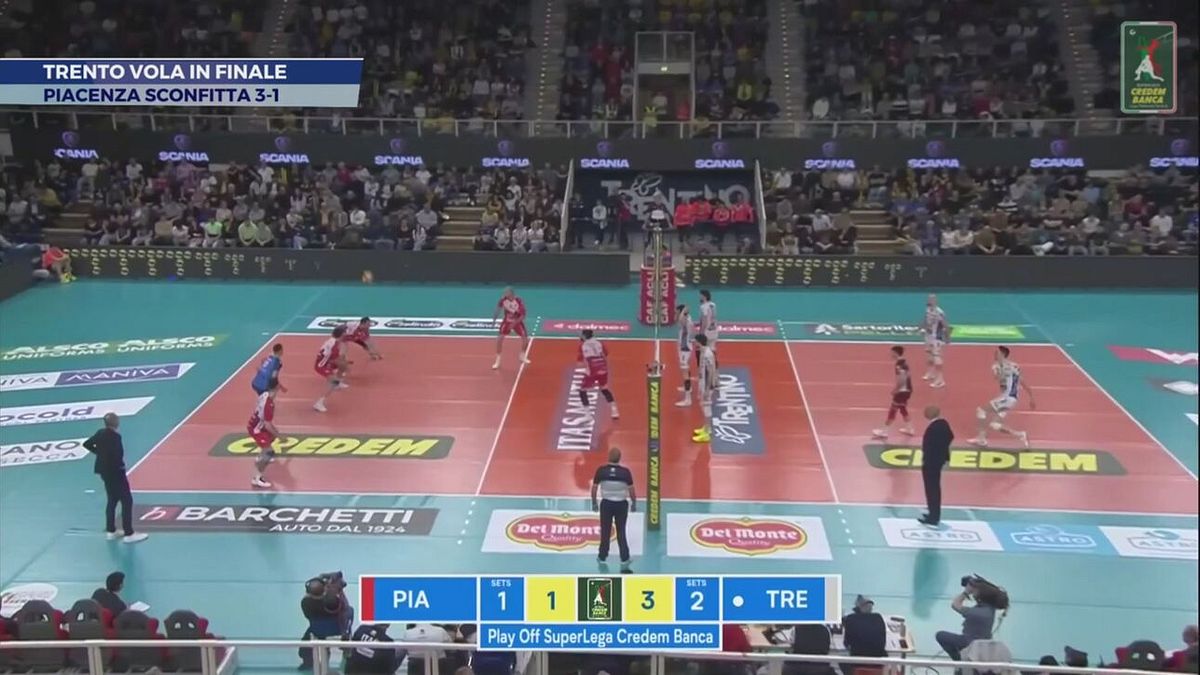Pancalli in esclusiva: "Così il mondo paralimpico sta cambiando l'Italia, ora serve un contagio culturale"
Il presidente del Comitato italiano paralimpico a Sportmediaset.it: "A PyeongChang potremmo sorprendere. La crisi in Figc? Troppi interessi politici..."
Serve prima di tutto una straordinaria motivazione per mettersi al comando dello sport paralimpico italiano. Servono poi altri due ingredienti precisi per restarci ininterrottamente dal 2000, vale a dire da quasi 18 anni: "Il fuoco e la passione sono fondamentali per mandare avanti una squadra. Quando uno è nel rettangolo di gioco, tutti devono avere la stessa passione perché se no rischi che qualcuno non ti aiuti a mettere la palla in rete". Luca Pancalli, rieletto presidente del Cip (Comitato italiano paralimpico) lo scorso 24 gennaio, dentro di sé ha un'energia rara che lo alimenta quotidianamente: "Non dimentico mai che i ragazzi per i quali oggi lavoro sono quel ragazzo che ero io quando, a 17 anni, all'improvviso mi sono trovato su una sedia a rotelle. Non devo dimenticare mai che io ho una responsabilità, soprattutto per quello che ho vissuto. Tutti noi abbiamo un 'fil rouge' che ci unisce e tutti siamo passati attraverso luoghi o momenti di sofferenza".
- Nel 2017 il Cip è diventato un ente pubblico, alla pari del Coni e dunque non più subordinato ad esso. Qual è l'aspetto più importante di questo cambiamento?
"Ne potremmo evidenziare infiniti. A mio modo di vedere, l'aspetto più rilevante è il fatto che si sia elevato a interesse della collettività e del Paese la mission del mondo paralimpico e della grande famiglia paralimpica; ovvero promuovere il diritto allo sport tra le persone disabili e contagiare positivamente la società attraverso l'immagine di atleti disabili, promuovendo una cultura che consenta di abbattere le barriere e non mi riferisco a quelle fisiche. Il fatto che il Cip sia diventato un ente pubblico significa averne sposato la mission e questo è veramente fondamentale".
- A che punto è oggi lo sport paralimpico italiano?
"E' esploso. E' esploso l'interesse intorno al mondo paralimpico e non è esploso per caso. E' il frutto di 17 anni di lavoro su tutti i fronti. E' un puzzle che si è andato costruendo in questi anni. E' esploso nella considerazione dell'organismo internazionale a cui facciamo riferimento. E' esploso nella considerazione dei media. E' esploso nella considerazione dell'immaginario collettivo, delle persone. Perché i nostri atleti raccontano straordinari risultati sportivi, ma raccontano anche storie umane. Raccontano storie attraverso le quali si lanciano messaggi positivi, di speranza e di valori".
- Che margini di crescita ha il mondo Paralimpico?
"Abbiamo raccolto grandi risultati sotto il profilo tecnico-agonistico, ma c'è ancora tantissimo da fare. E' come se oggi io avessi creato una macchina che potrà andare a 200 km/h, mentre fino a ieri non avevamo né la macchina, né la potenza per andare a quella velocità. E ci siamo organizzati. Oggi c'è la macchina, bisogna sapere guidare la macchina e bisogna fare quello che manca. Se noi pensiamo che le persone disabili che potenzialmente potrebbero essere coinvolte - ad esempio tra i 6 anni e i 45 anni - sono circa un milione, mentre noi grossomodo abbiamo circa 70mila persone tesserate, si capisce quanto ancora si possa crescere. E poi la vera sfida è la declinazione dello sport come strumento afferente a una dimensione squisitamente agonistica, ma che allo stesso tempo sia strumento di politiche attive per fare crescere la cultura del paese e il territorio. E' per questo motivo che noi abbiamo cominciato a lavorare da anni nei centri di riabilitazione e nei centri delle unità spinali ed è per questo che io spesso qualifico il mio movimento come un pezzo di welfare del mio paese. Perché quello che si vede sono le medaglie. Ma quello che è ancora più importante è ciò che non è visibile ed è tutto il resto".
- Lei guida lo sport paralimpico italiano dal 2000: qual è la cosa che più la rende fiera?
"E' difficile rispondere. Perché io da 17 anni, con grande umiltà e tanta passione, alzo metaforicamente la serranda del negozio alla mattina e la chiudo alla sera. Io ho avuto una visione: costruire pezzettino dopo pezzettino un intero puzzle. E forse la cosa di cui vado più fiero è non avere mai mollato la presa. Anche di fronte alle difficoltà, agli insuccessi e a chi magari si metteva di traverso, io non ho mai mollato la presa. Sono riuscito a trasportare nel mio lavoro di dirigente sportivo la caparbietà che avevo da atleta. Perché se l'atleta si fermasse al primo ostacolo, alla prima difficoltà o alla prima sconfitta, non vincerebbe mai. Ci vuole allenamento, allenamento e allenamento in vista di un obiettivo. E, oltre a questo, la cosa della quale onestamente vado più fiero è essere sempre stato uno tra i tanti. Con la mia umiltà, con una squadra intorno che non si è affidata ma si è fidata. E questo è un aspetto che premia la famiglia paralimpica. La cosa poi più romantica e di cui vado fiero è quando ti ringrazia una bambina di nove anni, sulla sedia a rotelle, con un sorriso. Lì capisci quello che hai fatto".
- Qual è la cosa che più la fa arrabbiare quando si parla di sport paralimpico?
"Ciò che mi fa arrabbiare è che non se ne parli. Poi che se ne parli bene o male, secondo me è comunque positivo. Perché significa che c'è un'attenzione. L'importante è che non ci si fermi alla superficialità del messaggio e si vada oltre. Mi arrabbio quando ci si ferma alla medaglia; quando non si capisce che noi stiamo lavorando per tutti gli altri 700mila che forse non diventeranno mai come i nostri campioni, ma che hanno un sacrosanto diritto allo sport come ciascuno di noi. Mi arrabbio quando non si capisce che dietro quella medaglia ci sono tantissimi ragazzi che non riusciranno mai ad arrivare: o perché nel loro territorio non ci sono impianti sportivi, o perché non ci sono tecnici, o perché non ce la fanno o perché hanno problemi fisici che non glielo consentiranno mai. Allora la cosa che mi fa arrabbiare è quando non si capisce che la nostra azione è volta sì alle Paralimpiadi, ma è anche volta a lasciare un segno. Vogliamo fare sì che un ragazzo tetraplegico grave possa passare delle ore in compagnia in maniera inclusiva e non esclusiva in una palestra sportiva, piuttosto che in una piscina. Vogliamo fare in modo che si metta in moto un meccanismo virtuoso dove oggettivamente parole come "inclusione, integrazione, normalità", siano qualcosa che noi riusciamo a declinare tutti i giorni attraverso lo sport".
- Da presidente del Cip, qual è l'errore da non commettere mai?
"Dimenticarmi da dove vengo. Non dimentico mai che i ragazzi per i quali oggi lavoro sono quel ragazzo che ero io quando a 17 anni, all'improvviso, mi sono trovato su una sedia a rotelle. Non devo dimenticare mai che io ho una responsabilità, soprattutto per quello che ho vissuto. Tutti noi abbiamo un 'fil rouge' che ci unisce e tutti siamo passati attraverso luoghi o momenti di sofferenza. Oggi la mia più grande soddisfazione è che in molti ci cercano perché vogliono legare la loro immagine ai nostri atleti. E questo non è accaduto per caso. Quello che mi piacerebbe che si capisse è che è stato un lavoro certosino, faticoso e umiliante per tante cose. Ed è un lavoro durato 17-18 anni. E un altro errore che non voglio commettere è rimanere legato a ciò che ho creato. Sto pensando da tempo a come e in quale modo costruire la generazione futura, perché noi non siamo eterni e forse anche noi ogni tanto abbiamo dei doveri nei confronti di noi stessi e delle persone che ci vogliono bene".
- Lo scorso gennaio, durante l'assemblea elettiva del Cip, ha parlato del suo desiderio di vedere Coni e Cip fondersi insieme un giorno, ovvero quando si saranno creati i presupposti culturali. Come si può sviluppare e diffondere questa cultura?
"Facendo quello che sto facendo con te, ad esempio. Tu sei un giornalista e quando parli di attività sportiva praticata da persone disabili, usi il termine paralimpico. Ti viene normale, nessuno ti ha detto che lo dovevi fare. Io ho cominciato a immaginare questo risultato circa 15 anni fa, quando a un certo punto ho cominciato a parlare perché non volevo che il termine disabile prevalesse sulla dimensione sportiva. E quindi non volevo che l'aggettivazione corporea della propria condizione fisica, psichica o sensoriale prevalesse sullo sport. Così ho abbandonato la vecchia terminologia (prima del 2005 il Cip si chiamava 'Federazione italiana sport disabili', ndr) per approdare al concetto del paralimpismo. L'obiettivo era creare un percorso che culturalmente portasse la gente a dimenticare come siamo fatti, perché prevaleva la dimensione sportiva. Faccio questo esempio perché la cultura non si cambia con le rivoluzioni o con l'attimo fuggente della compassione e dell'emozione. La cultura si cambia con un lento processo riformatore, che piano piano porti a contagiare le persone. I giornalisti di oggi non scrivono come scrivevano i giornalisti di 18 anni fa. E' un dato di fatto, prendete i giornali di 18 anni fa e guardate la differenza. Quella differenza l'abbiamo fatta noi e questo è un orgoglio. Poi è chiaro che c'è stato un allineamento perfetto di pianeti, perché un lavoro che è stato certosino ha intercettato dei grandi campioni e testimonial come Alex Zanardi, Bebe Vio, Martina Caironi, Federico Morlacchi, Daniele Cassioli, Annalisa Minetti. Ma quei campioni c'erano pure 20 anni fa, però non avevano questa opportunità. Quindi la cosa che potrà creare quell'elemento essenziale per arrivare a quella fusione (tra Coni e Cip, ndr) che è ancora il mio sogno, è il contagio culturale. Dobbiamo creare le precondizioni affinché non ci sia un calo di attenzione sugli anelli più fragili della comunità e, per farlo, questa cultura deve diventare un patrimonio degli uomini che nei prossimi anni andranno a gestire il Comitato paralimpico, il Coni, il Ministero dello sport piuttosto che il Governo".
- A PyeongChang sono ora in corso le Olimpiadi invernali, poi il 9 marzo toccherà a voi con le Paralimpiadi. Qual è l'obiettivo dell'Italia?
"L'obiettivo è fare meglio di Sochi e non ci vorrà molto, perché Sochi per noi è stata un'esperienza da dimenticare. Io sono soddisfatto del lavoro intrapreso dalla Federazione sport paralimpici invernali. Abbiamo dei giovani che potrebbero rappresentare una sorpresa sulle nevi di PyeongChang e abbiamo una straordinaria squadra di hockey su ghiaccio che non ha mai mollato e potrebbe regalarci qualche risultato strabiliante. Sono sereno perché peggio di Sochi non possiamo fare. Sono anche contento perché una paralimpiade per noi è sempre un momento di verifica di quello che abbiamo fatto. E non la vivo con grande ansia, la vivo con equilibrio perché so che le federazioni hanno fatto il massimo che potevano fare e noi, come Comitato paralimpico, lo stesso".
- Quante medaglie possiamo vincere?
"So che il presidente Malagò ha fatto stime a doppia cifra per le Olimpiadi, mentre io non faccio stime. Mi accontenterei di lasciare lo zero, perché questo è stato il risultato di Sochi".
- Parentesi sul calcio, visto che nel settembre 2006 fu nominato commissario straordinario della Figc e oggi la federazione è stata nuovamente commissariata dopo il fallimento di Tavecchio. Qual è la situazione del calcio italiano?
"Bisogna distinguere la dimensione sportiva - come quella della delusione della non qualificazione al Mondiale o quella anche dei milioni di bambini e ragazzi in giro per l'Italia che riempiono i campi di calcio - dalla dimensione organizzativa, che è fatta dalla politica. Ci sono momenti in cui si vince e momenti in cui si perde, ma non bisogna dimenticare che c'è un grande movimento. La dimensione organizzativa ha mostrato le proprie fragilità e mi auguro che da questo possa nascere un percorso nuovo e virtuoso. In genere bisogna sempre passare da momenti bui per riuscire a rivedere la luce. Mi auguro che una situazione come quella che si è creata - che credo non abbia eguali nella storia tra l'esclusione dai Mondiali e una Figc e Lega di A commissariate - possa veramente determinare il giusto equilibrio e la giusta sensibilità per ripartire".
- Prima che venisse nominato Fabbricini, qualcuno fece il suo nome come possibile commissario Figc. E' davvero esistita questa possibilità?
"No, nella maniera più assoluta".
- Di chi sono le maggiori responsabilità dell'attuale situazione del calcio italiano?
"Io non sono nessuno per dirlo e non ho nemmeno l'arroganza per poter sottolineare di chi siano le responsabilità. In quel mondo ci sono stato e, sulla base della mia piccolissima esperienza, ho capito che è difficile governare un mondo dove ogni componente è portatrice di interessi particolari e contrapposti. Perché poi bisogna trovare un momento di condivisione, equilibrio e scelte comuni sostenute da tutti e quella è la cosa più complicata. Se tutti hanno un'idea diversa perché tutti vogliono fare una cosa diversa, diventa difficile da gestire. Bisognerebbe mettere sopra un tavolo tutte le problematiche in maniera franca, trasparente, seria. Ma lì, in quel momento, tutti devono sapere che qualcosa dovranno lasciare su quel tavolo per un bene più grande che è l'interesse del movimento calcistico italiano".
- Tornando allo sport paralimpico: che cosa si sente di dire a chi ancora conosce troppo poco questo mondo?
"Voglio dire di non avere paura di ciò che non si conosce. Bisogna aprirsi con profondità. Bisogna andare oltre la superficialità dell'apparenza".
- Che cosa vuole dire, invece, ai ragazzi che hanno una disabilità?
"Non vi lasciate piegare da una società che ha fatto dell'apparenza un valore. Non lasciatevi piegare dall'apparenza, ma ricordatevi che siamo sostanza. E sostanza significa essere prima di tutto persone con le proprie carrozzine, con la propria cecità, con i propri pezzi di fisico e di corpo che mancano, con la propria disarticolazione della parola. Ma sempre persone, che vanno tutelate, in primis, in quanto persone. Quindi non lasciatevi scoraggiare da una società che tende a emarginare chi è l'anello fragile della stessa. Una società che predica pari opportunità e inclusione ma dentro la quale, in realtà, si fatica tantissimo. Perché mi sembra alluncinante che parliamo oggi di problemi dei quali parlavamo 37 anni fa. Vedete, io mi occupo di sport ma mi occupo anche di quei ragazzi che non potranno mai fare sport, perché hanno delle disabilità gravissime. Mi preoccupo di quelle famiglie che sono abbandonate e lasciate sole, con poche ore di assistenza domiciliare. E allora, per questo motivo, non fermatevi alla superficialità. Non fermatevi al sorriso dei nostri atleti e dei nostri campioni, perché dietro ci sono persone che non diventeranno mai campioni e che noi dobbiamo aiutare, con i riflettori dello sport, a essere campioni di vita".
- Com'è lo sport nel suo mondo ideale?
"E' quello paralimpico (ride e poi torna subito serio, ndr). Tutti parlano di una fusione del mondo olimpico e paralimpico, olimpiadi e paralimpiadi. Ma può darsi che il mondo olimpico un giorno debba essere diffuso attraverso le paralimpiadi, perché saremo così bravi e così capaci di comunicare l'essenza dello sport che travalica il risultato agonistico. Ma questo nel mondo fantascientifico. Il mio mondo ideale dello sport è quello che riesce a tenere insieme l'agonismo con il sociale; è quello che riesce a tenere insieme l'agonismo con la cultura; è quello che riesce a tenere insieme l'agonismo con la speranza e con la politica, con la crescita del territorio, con la crescita della dimensione umana delle persone, con la crescita del Paese".
- Qual è il sogno del presidente Pancalli?
"Non lo so, perché io non vivo di sogni ma di obiettivi. Ho sempre vissuto di obiettivi. Oggi l'obiettivo è vedere il Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane di Roma (il primo centro sportivo polifunzionale, ideato e realizzato per favorire l'attività sportiva delle persone con disabilità, ndr) riempito di speranze, di giovani, di ragazzi. Vedere realizzato il mio obiettivo di fare dello sport la fase 2 della dimensione di recupero dei ragazzi che hanno avuto incidenti. Il mio obiettivo è vedere realizzati altri centri in giro per l'Italia che possano rappresentare una luce in fondo a quel tunnel che abbiamo vissuto tutti quando in un letto di ospedale, in una sala di rianimazione, ci siamo risvegliati da un incidente o quando magari, dopo una patologia, ci è stato comunicato che non saremmo stati più quelli di prima. Si tratta di retorica? Non lo so. A volte la retorica, se diventa sostanza, può cambiare un mondo".