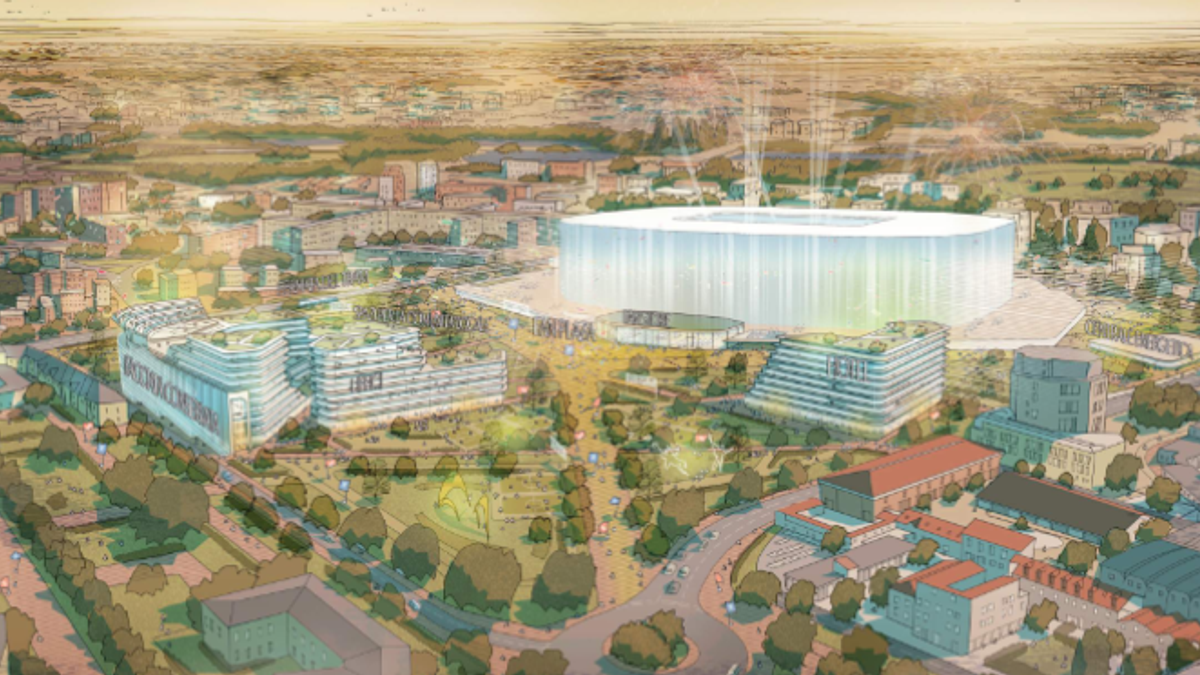L'eredità di Paolo Rossi: molto più di quei sei gol
Quei novanta minuti contro il Brasile rivoluzionarono l'Italia calcistica, e non solo
di Enzo Palladini
Se è vero – come è vero – che esiste un calcio italiano “pre-Sacchi” e un calcio italiano totalmente diverso “dopo Sacchi”, è altrettanto logico parlare di un pre-Pablito e di un post-Pablito. Un punto di svolta che ha coinvolto tutto e tutti, che ha fatto decollare l’Italia calcistica portandola sul tetto del mondo. I trionfi degli anni ’90 e l’appeal mondiale dei nostri club non ci sarebbero stati senza quei gol. Ma sì, cosa possono essere mai novanta minuti in una vita. Un’ora e mezza, un pisolino. Anzi no. Novanta minuti possono rivoluzionare un mondo, dipende da come vengono impiegati. In quel pomeriggio all’ormai polverizzato stadio Sarrià di Barcellona, Paolo Rossi cambiò il destino di una nazione e non solo dal punto di vista calcistico. Quel pomeriggio e non la sera della finale, perché la vittoria sul Brasile, quella fu la genesi di tutto.
Come ha detto più volte Zico, una volta battuto quel Brasile, l’Italia non avrebbe più potuto temere alcun avversario. Aveva la strada spianata verso un titolo che nessuno avrebbe potuto toglierle. Tutto quasi scontato, compresa la doppietta di Pablito nella semifinale contro la Polonia, compreso l’urlo di Tardelli, compreso il balletto di Altobelli per segnare il gol che ci diede la certezza del titolo mondiale.
Quella manciata folle di giorni e di emozioni nel 1982 fece svoltare tutto un Paese. Le giovani generazioni non hanno ben presente quale fosse il clima in Italia negli anni precedenti quel Mundial. Gli anni ’70, universalmente conosciuti come “gli anni di piombo”, avevano messo in ginocchio le grandi città. Il terrorismo era un incubo per tutti, si sparava per le strade con una facilità che oggi nessuno potrebbe immaginare, la lotta politica, spesso strumentalizzata a favore del caos generale, infuriava attraverso i pochi mezzi leciti e i molti illeciti che il momento storico consentiva tacitamente di utilizzare. C’era poco da scherzare, c’erano tensioni interne e altissime tensioni internazionali. E per non farsi mancare niente, l’Italia aveva subìto anche due tragedie immani, il terremoto del Friuli nel 1976 e quello dell’Irpinia nel 1980, morte e devastazione dall’estremo nord al quasi estremo sud, faticose ricostruzioni e la paura che tutto potesse precipitare ulteriormente.
Il calcio italiano non sfuggiva a questa situazione ad elevato tasso di drammaticità. Negli anni ’70 c’era stata una totale autarchia, frontiere chiuse e tentativo di valorizzare completamente il made in Italy. Però la Nazionale aveva raccolto poco, il quarto posto nel ’78 in Argentina. Punto. Per i club, una Coppa delle Coppe con il Milan e una Coppa Uefa con la Juventus. Un decennio avaro, conclusosi nel peggiore dei modi, con il primo scandalo del calcio scommesse che aveva mutilato la nazionale azzurra proprio alla vigilia dell’Europeo 1980 giocato in casa. La partita con il Belgio di quel torneo fu il simbolo della parziale inadeguatezza del calcio italiano nel suo insieme: gli azzurri giocavano come si giocava dieci anni prima, i belgi facevano zona, fuorigioco e pressing. Si portarono via uno 0-0 preziosissimo e andarono in finale contro la Germania.
Ma poi è cambiato tutto, in un torrido pomeriggio di luglio a Barcellona. Perché quel giorno l’Italia del calcio smise di guardare gli altri dal basso in alto, smise di pensare che certe nazionali erano su un piedistallo inarrivabile. Battendo il Brasile ci si rese conto che si poteva fare tutto. Non a caso (o forse per una coincidenza astrale) in quell’estate del 1982 la Figc aprì il tesseramento per la Serie A al secondo straniero (nei due anni precedenti ogni club ne poteva avere uno soltanto), arrivarono nomi già famosi come Michel Platini e Zibì Boniek alla Juventus, Ramon Diaz al Napoli, Trevor Francis alla Sampdoria. Sembrava un particolare secondario prima che la Nazionale partisse per la Spagna, ma dopo l’11 luglio, con giusta enfasi, tutti i media italiani cominciarono a raccontare con enfasi, che si stava per cominciare “il campionato dei campioni del mondo”.
Due anni. Altri due anni e le iperboli cominciarono a moltiplicarsi. Perché è vero che da una parte il gruppo dei campioni del mondo arrancava in una complicata qualificazione europea (poi fallita), ma è altrettanto vero che il nostro campionato stava diventando appetibile per chiunque. Nel 1983 al novero dei campioni già presenti si aggiunsero altri nomi pesanti: Zico all’Udinese (operazione impensabile fino a un anno prima), Toninho Cerezo alla Roma, Hansi Muller all’Inter. L’anno successivo, 1984, arrivarono Maradona al Napoli e Rummenigge all’Inter. Il passaggio dal “campionato del campioni del mondo” al “campionato più bello del mondo” fu rapidissimo, quasi impercettibile. E tutto l’indotto ne beneficiava, perché i giornali sportivi vendevano come non avevano mai venduto prima e come non avrebbero mai più venduto dopo, gli stadi tornavano a riempirsi dopo anni di stanca. L’Italia era diventato il Paese del calcio, il tutto grazie a quel pomeriggio del Sarrià, grazie al signor Paolo Rossi che intanto senza farsi troppo notare scivolava verso la fine della sua carriera, datata 1987.
E l’Italia, intesa come Paese, andava nella stessa direzione. Mentre gli azzurri si fregiavano del titolo di campioni del mondo, la politica prendeva una direzione completamente nuova. Messo da parte il potenziale compromesso storico di metà anni ’70, si registrava l’ascesa di Bettino Craxi, il popolo italiano ammirava gli splendori della Prima Repubblica quando ancora se ne ignoravano le miserie esplose negli anni ’90. Nasceva la Milano da bere, tornava la Roma di una Dolce Vita post litteram, si sentivano tutti più ricchi e tutti più felici. Magari era un castello di carte, ma nessuno potrà mai smentire che dietro quegli anni di apparente benessere generale ci fosse l’impulso di quel Mondiale che aveva cancellato tante amarezze e regalato tante gioie agli italiani. Se Tangentopoli nei primi anni ’90 cancellò Craxi e il Craxismo con un conseguente stravolgimento di certe logiche, il mondo del calcio invece non lasciò che l’impeto si frenasse, portando in serie A altri campioni e soprattutto – e qui si innesta la rivoluzione sacchiana – moltissimi altri trofei internazionali.
Ma Paolo Rossi ha molti altri debitori tra i suoi colleghi e potenziali allievi. Tutti i calciatori che hanno calcato i grandi palcoscenici gli devono qualcosa. Sì, anche Cristiano Ronaldo e Messi. Perché Pablito è stato il primo calciatore di un’intelligenza superiore alla media nel campo degli affari. È stato il primo uomo immagine, il primo a spostarsi dalla logica di “uno del gruppo” prestando il suo volto a tutto quello che la logica e un rigore morale di fondo permettessero. Certo, non tutti avevano fatto piangere il Brasile, non tutti avevano regalato un Mondiale all’Italia, soprattutto – sia chiarissimo – non tutti avevano un sorriso spontaneo e rassicurante come il suo. Ma dopo, dopo di lui, anche chi non ha fatto tutto questo ha trovato terreno fertile per crearsi un piccolo impero. Tutto questo, ma anche molto altro, è l’eredità che Pablito lascia dopo essersene andato così presto. Per questo manca così tanto.