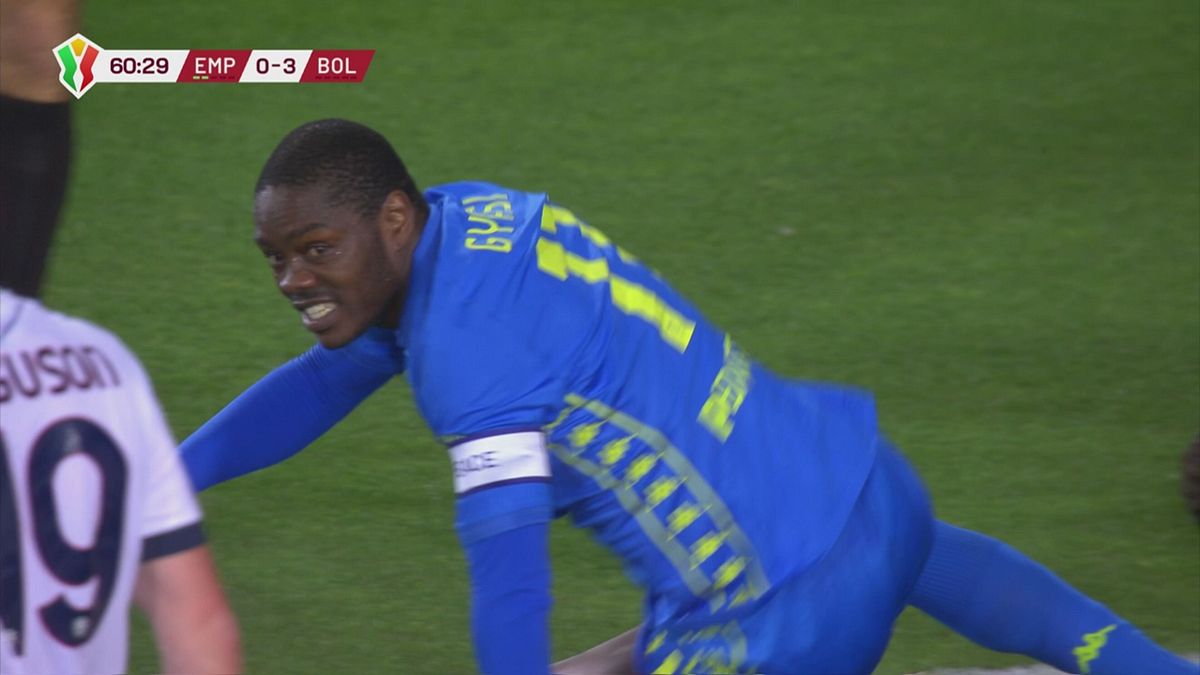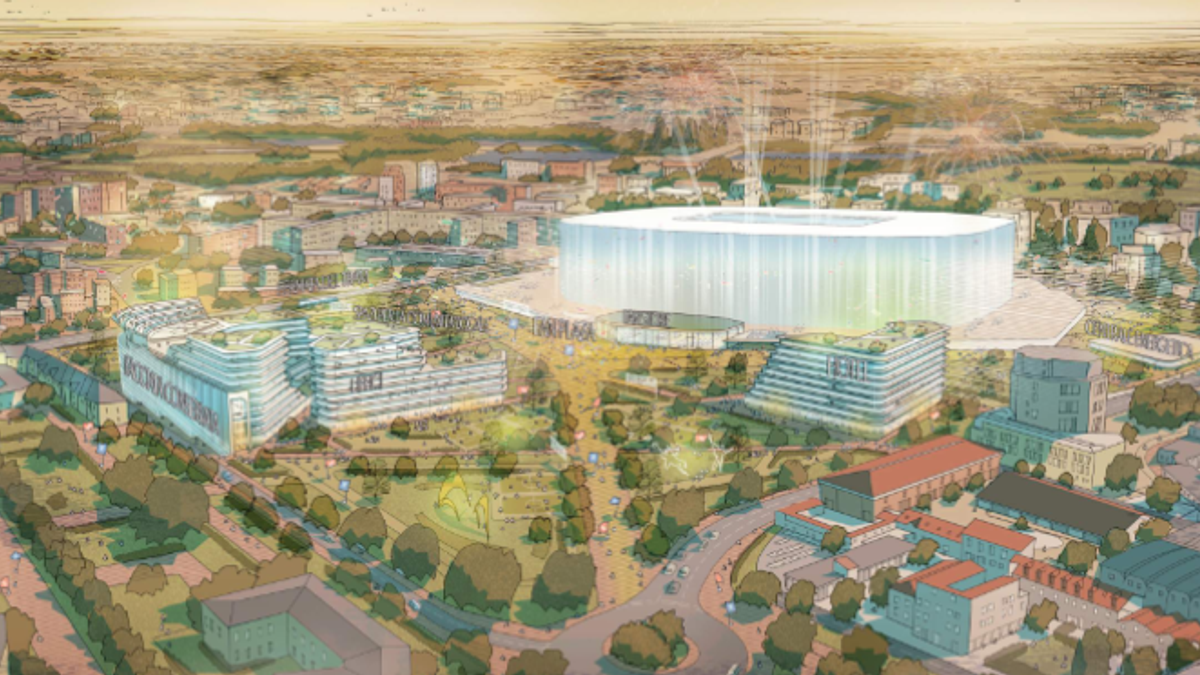Saponara, lettera ad Astori: "Ciao Davide, saresti fiero di me"
Dalle passioni comuni al racconto di quel tragico 4 marzo 2018 passando per la grande amicizia e lezioni da leader dell'ex capitano della Viola

A tre anni dalla scomparsa di Davide Astori, Riccardo Saponara ha scritto una lunga lettera all'ex compagno di squadra . Una lettera emozionate, piena di ricordi e aneddoti che svelano a "Cronache di spogliatoio" la storia di un'amicizia speciale e di un rapporto unico dentro e fuori dal campo. Dalle passioni per il cinema, la cucina e il design al racconto di quel tragico 4 marzo 2018 passando per i consigli da leader dello spogliatoio dell'ex capitano della Fiorentina. Consigli che Saponara ha deciso di seguire nella sua nuova avventura allo Spezia ricavandone una grande lezione di vita.
Ecco il testo integrale della lettera:
“Ricky, hai visto? La La Land ha vinto l’Oscar. Chissà se lo merita davvero”.
"Non lo so Asto, ma appena esce in Italia ce lo dobbiamo vedere per forza. E lo giudichiamo senza pietà, come sempre".
“Va bene Ricky, vediamo se davvero si è meritato l’Oscar”.
Se penso alla vita che si ferma improvvisamente, che ti lascia senza fiato e si spezza senza chiedere il permesso, penso a questo momento. Perché Davide era arredatore di interni, esperto di cinema di nicchia, cuoco, amante delle serie tv, il classico tuttologo. Non c’era cosa che non conoscesse. Un tipo strano per il calcio, ma il mio tipo preferito. Come ripeteva sempre, lui si sentiva un designer che nel tempo libero diventava calciatore. Se penso alla vita che ti lascia senza lo spazio di recuperare il tempo perduto, penso a La La Land. Il film che avrei dovuto vedere con Asto, il film che ho visto da solo. Una sensazione di impotenza, di privazione. L’ho guardato tante volte in questi anni. Ha un significato speciale per me: per la relazione con la ragazza dell’epoca, per il significato in sé del film. Per quell’amico a cui avevo promesso un giudizio. Asto, sì, te lo posso dire: merita davvero l’Oscar.
Sono passati tre anni e mi manca la tua spalla. Eravamo seduti accanto in sala pranzo, e sai che spesso mi appoggiavo a te come si fa con un fratello maggiore. Mi hai dimostrato di essere una persona unica, un leader diverso. Come quella volta in cui ho firmato con la Fiorentina. Il Team Manager mi inserì nel gruppo WhatsApp ed ero soltanto un numero nella rubrica di molti, come accade quando si cambia squadra. Un +39 anonimo dentro a un cellulare. E invece no: tu chiedesti il mio contatto e mi scrivesti subito. “Per qualsiasi cosa, conta pure su di me”. Parole semplici, ma che in quel momento mi hanno fatto sentire meno solo. Non ci conoscevamo, ma lo spavento che provavo nell’entrare in uno spogliatoio nuovo dopo tre anni a Empoli fu spazzato via in un secondo. Mi hai sempre dimostrato cosa significasse per te essere un amico, nei piccoli gesti quotidiani. Te lo avevo detto quel giorno: “Guarda che oggi non gioco”. Tu, invece, testardo, mi ripetevi che sarei stato titolare. Lo facevi per me, lo so, ma alla fine il mister mi mandò in tribuna, addirittura. A volte rileggo quel messaggio che mi inviasti durante il tragitto verso lo stadio: “Stai andando bene, stai crescendo. Oggi non giochi, ma sei sulla strada giusta per tornare al tuo livello. Continua così”.
Sapevi motivare, sapevi riprendere, sapevi quando arrabbiarti, sapevi quando scherzare, e come farlo. Come quel sabato sera a Udine. Io, te e Marco (Sportiello, ndr) a cazzeggiare. Abbiamo parlato un po’ e poi vi siete messi a giocare alla Play. Maledetti. Lo sapevate che non mi piaceva giocarci, vi odiavo quando vi piazzavate davanti a quello schermo a urlare come pazzi incollati a Fifa. Quindi me ne andai in camera. La mattina scesi per fare colazione. Vidi le tue scarpe appoggiate fuori dalla camera di Marco. Se le sarà dimenticate lì ieri sera, pensai. Le tue posate, il tuo piatto e il tuo tovagliolo erano intatti. Strano, eri sempre il primo. Sarà stato un cameriere a cambiare il coperto. Non ci feci caso. Tornai in camera da Vincent Laurini, il mio compagno di stanza, per trascorrere le due ore prima del pranzo. Sentii il rumore di un’ambulanza e mi affacciai alla finestra. I portelloni sul retro erano aperti, le luci lampeggiavano di un blu più freddo del solito. C’era anche Leo, il nostro magazziniere, che camminava avanti e indietro nel parcheggio, fumando una sigaretta. La stava consumando tre tiri alla volta, in modo nervoso. “Leo, che fai?”.
Aveva la voce rotta, non riuscivo a comprendere la sua risposta. Mi sporsi dalla finestra per avvicinarmi a lui. Forse l’avevo già sentita, ma il mio cervello si rifiutava di recepirla, di incamerarla, di accettarla. Come un impulso che porta a un netto rifiuto. “Davide è morto!”. Il vuoto, una scarica elettrica che ti paralizza. Non riuscivo a percepire la sua voce fino in fondo. O forse non volevo. Gli chiesi di ripetere una seconda volta, e lo fece. Mi voltai verso Vincent con gli occhi sbarrati. Come avrei dovuto comunicargli una cosa del genere? Non ci fu il tempo, perché qualcuno bussò alla porta della nostra camera. Aprii con la forza di chi ha smarrito il proprio io, di chi non è padrone del proprio corpo per qualche secondo. Era il mister. C’era Stefano Pioli in lacrime: “Davide non c’è più”. Continuava a piangere, lacrime implacabili. Mi abbracciò forte, un gesto che avvertii come disperato. Fu in quel momento che mi affacciai al corridoio. Alcuni miei compagni erano a terra, pietrificati. Altri si rifiutavano di accettare che fosse accaduto davvero, che fosse accaduto a Davide. Sentivo i pugni sbattere sulle pareti dell’hotel. Urla di rabbia e dolore: “Come cazzo è possibile!!!”. Cercavano di capire perché la vita era stata così infame. Ma una risposta non c’era e non c’è nemmeno ora. Ricordo di aver sentito distintamente le urla di Fede (Chiesa, ndc), che era appena stato svegliato con quella notizia. Erano urla di disperazione, incontrollate. Stava spaccando tutto in camera, era in preda al raptus di chi non accetterà mai quella sentenza. Mi diressi verso la stanza di Davide. Intravidi i suoi piedi, ma non ebbi il coraggio di entrare.
Seguirono ore di silenzio, rientrammo a Firenze e i tifosi ci riservarono un lungo applauso, che risuonava in un silenzio composto da commozione e rispetto. Ci ritrovammo due giorni dopo al centro sportivo, dopo il lunedì trascorso a casa per cercare risposte. Eravamo in palestra e il primo a parlare fu Pantaleo Corvino, il nostro direttore generale. E fu sincero: “Io una cosa così non l’ho mai vissuta, non so come la vivrete voi. Per me potete smettere di giocare oggi, non ha importanza quello che succede da qui al termine della stagione. Non so come andremo avanti”. Parlò anche Milan (Badelj, ndr), e lo fece con un discorso ancor più intimo rispetto a quello che pronunciò durante il funerale di Davide nella Chiesa di Santa Croce. Fu speciale anche il primo momento in cui ci guardammo tutti negli occhi. Milan ci esortò a continuare nel suo ricordo, a riprodurre quei comportamenti che ci aveva insegnato. Quel martedì fu strano, non saprei come altro definirlo. C’era un’aria particolare. C’era chi si allenava con le lacrime agli occhi, chi non riusciva a pronunciare neanche mezza parola, chi sfogava rabbia e frustrazione durante la partitella. Io mi ero tenuto tutto dentro. Tutto. Chiuso a chiave dentro di me. Ma sapevo che sarei crollato, in quella giornata o in un’altra. Era questione di ore. Accadde quando entrai in sala pranzo, mi sedetti e al suo posto non c’era nessuno. Era vuoto. Non c’era nessuna spalla sulla quale appoggiare la mia testa. Non riuscii a contenere le lacrime. Quello era il mio momento. Non l’ultimo.
Lo sfogo della consapevolezza è arrivato durante la camera ardente a Coverciano. La famiglia aveva designato poche persone per un ultimo saluto prima dell’apertura al pubblico. Ebbi l’opportunità di salutare Davide prima che il feretro venisse chiuso. C’erano alcuni compagni di squadra, altri della Nazionale, come Daniele De Rossi, e qualche amico. Il suo corpo era coperto di ematomi, non era più lui. Io avevo gli occhi gonfi di lacrime, non riuscii neanche a vederlo in modo nitido. Lì ho capito quello che era successo, al dolore si è aggiunta la consapevolezza che non saremmo stati mai più insieme a guardare quel film o a mangiare in quel ristorante in cui dovevamo andare. Mi ero scaricato a livello nervoso. Non mi sono mai spiegato perché la gara contro il Benevento non sia stata rinviata dopo quella settimana devastante. Il fischio finale fu una liberazione, la fine di quel calvario durato 7 giorni. Un mix di tristezza e risonanza mediatica che non ci permise di avere privacy durante l’elaborazione del lutto. Giocare quella partita era l’ultimo desiderio di ognuno di noi. Ma fu anche l’inizio di una cavalcata incredibile all’inseguimento della qualificazione all’Europa League dopo una stagione anonima. Ogni lunedì Pioli, in palestra, analizzava il weekend e toccava i punti giusti. Si era creato un legame quasi ascetico. Nel nome di Davide. Non era facile parlarne, ma attraverso il ‘Saluto del Capitano’ trovammo il modo per onorarlo e rivivere la sua essenza.
Perché per noi la sua scomparsa è rimasta un tabù, ma ciò che ci ha lasciato è una prova tangibile. Un mese fa ho incontrato Veretout, l’ho affrontato due volte in pochi giorni. A Firenze, Jordan non parlava italiano, non avevamo legato molto. Non interagivamo e io ho bisogno di parlare con le persone per entrare davvero in profondità. Però quando ci siamo ritrovati dopo tanto tempo, era come se fossimo amici di vecchia data. Dialogavamo in modo fluido come due persone che avevano condiviso qualcosa di inscindibile, anche senza parlarsi. Come se Davide fosse la lingua universale che ci ha unito per sempre. Quando incontro un mio ex compagno alla Fiorentina è così, nessuno dei due affronta l’argomento. Credo che abbiamo paura di come l’altro potrebbe reagire dentro di sé. Nell’abbraccio che ci diamo per salutarci, però, implicitamente ci mettiamo tutto. E ogni volta è speciale. Le sue doti umane erano innate. Se stavi facendo un esercizio e accanto a te c’era un ragazzo straniero, che non conosceva la lingua, correva a rompere il silenzio inventandosi parole e facendolo sentire a suo agio. Poteva non parlare la lingua del compagno, ma non faceva alcuna differenza. Finiva tutto con una risata. Era il collante. Il leader che non ha bisogno dell’ufficialità della fascia per essere riconosciuto. In quella squadra così multietnica, lo spogliatoio non si era amalgamato automaticamente all’inizio. Il suo intervento fu fondamentale. E quando venne a mancare ci accorgemmo di quanto fosse pesante la sua presenza. Solo quando perdi qualcosa ti accorgi del suo reale valore, è vero, ma la sua forza era indiscutibile. E così sarà per sempre.
“Vengo a prenderti, andiamo insieme”. Ti ricordi di quando siamo andati con la tua Smart alla cena di squadra? Fu uno dei primi momenti vissuti accanto fuori dal contesto calcistico. In quei venti minuti sublimammo la nostra amicizia. Parlammo di valori, di progetti, di futuro. Sancimmo definitivamente il legame umano che ci univa. Un patto profondo. Mi hai lasciato una maturità superiore, quella con cui oggi vivo il calcio. Prima lo facevo con ansia: si vince, si vive bene. Si perde, la settimana sarà una merda. No. Grazie a te ho capito che il calcio è una parte della vita e che è proprio l’equilibrio fuori dal campo che ti porta ad affrontare con maggiore positività la tua professione. Mi hai mostrato che puoi essere calciatore, ma anche designer di interni, critico cinematografico e appassionato della materia più impensabile. La vita merita di essere vissuta con serenità, comunque vadano le cose. Ed è quello che voglio trasmettere agli altri. Sono una persona introversa, e ho capito che non c’è niente di male. Che vado bene così.
Sai, qualche giorno fa saresti stato fiero di me. Agudelo, un mio compagno che viene dal Sud America come tanti dei nostri amici alla Fiorentina, ha discusso con il mister durante l’allenamento. E si era offeso. Era stato escluso dalla partitella e, dopo qualche minuto, il preparatore gli ha restituito la casacca per tornare in campo. E lui no, non voleva. Se l’era presa. Allora gli ho detto: “Dai, non fare così. Torna in campo e basta”. Con i tuoi modi, quelli giusti per non creare un precedente. Negli spogliatoi era ancora arrabbiato. Ma io non volevo che quel comportamento lo rovinasse. L’ho preso da parte: “Ascoltami. Sai che devi ritenerti fortunato? Il mister si è incazzato, ti ha escluso, e dovresti essere orgoglioso di lui. Cosa avresti voluto? Uno che non ti dice nulla, fa finta di niente, e la domenica ti lascia in panchina senza spiegazioni? Senza che tu possa capire i tuoi errori e migliorare? Devi ritenerti fortunato, lo avrei voluto incontrare anche io da giovane un allenatore così”. Non mi ha risposto. Il giorno della partita ero nello spogliatoio e mi stavo lavando i denti, l’ho visto entrare: “Riccardo, avevi ragione. Ti devo ringraziare, oggi gioco titolare”.
Grazie Asto, ti voglio bene