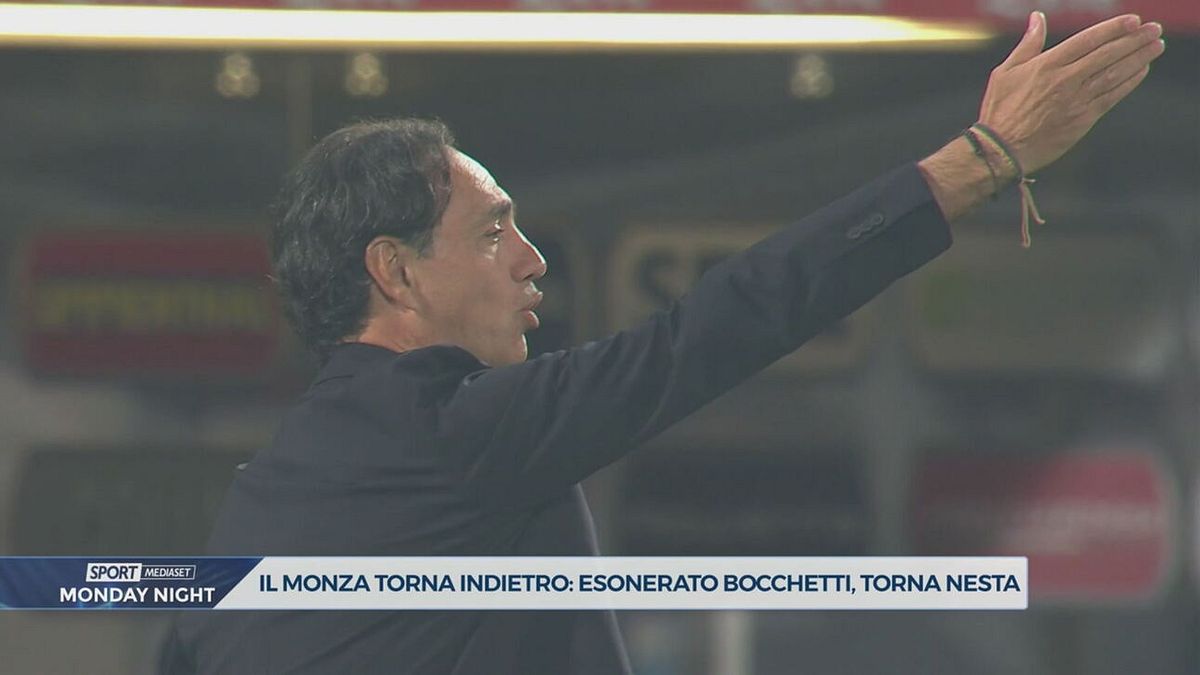Arshavin, vivere per poter sprecare
Il russo è stato un calciatore sublime, ma...

Steso sul pavimento la stanza pareva più piccola ancora e l’appartamento, con sua madre accanto, minuscolo; c’era spazio appena per stendere le gambe e a dodici anni, in quelle condizioni, crescere pareva una colpa perché toglievi centimetri alla casa. Il papà di Andrej era andato via, non andava d’accordo con la mamma, era stato un pessimo giocatore dilettante e portava spesso Andrej ai campi di calcio, per vederlo giocare.
Fuori l’appartamento, in uno dei tanti palazzi popolari di San Pietroburgo (lui, però, era nato quando ancora si chiamava Leningrado) rabbuiava indifferente sul dolore dei suoi abitanti che erano diventati ex sovietici ancor prima di poter tornare a essere russi. La stanza stringeva e faceva male, la città non era abituata a quei rumori e a quella povertà che fino a pochi anni prima veniva considerata eguaglianza sociale; lui, il piccolo Andrej, quando aveva solo sette anni, non ne voleva sapere della scuola e allora aveva buttato dalla finestra il registro di classe, facendosi espellere; un tale atto di insubordinazione nell’Unione Sovietica terminale (siamo nel 1988) non veniva concesso nemmeno a un bambino.